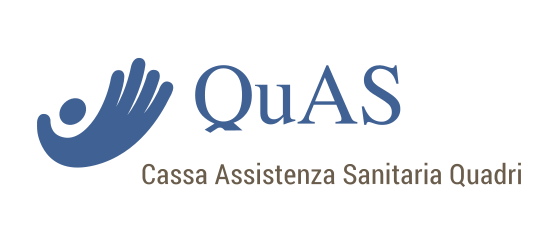Il lavoro dal Premio Nobel a Celentano
In Italia si è aperto il dibattito per l’introduzione in via sperimentale della settimana lavorativa corta (32 ore anziché 40, a parità di salario); l’eventualità di un intervento normativo sembra per ora rinviata per gli inevitabili effetti onerosi per la finanza pubblica, stimati in circa 8 miliardi di euro, ma anche (ci si augura) per i danni economici ed organizzativi che un provvedimento di questa portata causerebbe alle imprese.
In un momento in cui “mancano 258 mila lavoratori nel Terziario”, come ha recentemente ricordato il Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, un provvedimento di riduzione dell’orario di lavoro aggreverebbe ulteriormente il problema della mancanza di lavoratori qualificati, con impatti negativi sulla crescita economica e l’andamento del PIL dell’intero Paese.
Per non parlare poi del fatto che una delle ragioni maggiori del deficit di competitività italiano sta proprio nei bassi tassi di produttività: prima di pensare a lavorare “meno”, bisognerebbe forse pensare a come lavorare “meglio”.
James M. Buchanan (1919-2013), Premio Nobel 1986 per l’Economia, ha scritto in tempi non sospetti il saggio: “Perché dobbiamo lavorare di più e risparmiare di più. Il valore economico dell’etica del lavoro”, dove sostiene che le disuguaglianze di reddito hanno una spiegazione anche nella quantità di tempo dedicato al lavoro.
Consapevoli che per alcune categorie di soggetti, soprattutto i giovani, la correlazione “più impegno lavorativo, più risorse economiche” si è drammaticamente interrotta, è però altrettanto vero che nel dibattito pubblico risulta pressoché assente il tema dell’etica del lavoro, sorpassato da argomenti pieni di ideologia.
Non si lavora solo per mantenere la famiglia, rimborsare il mutuo, comprare beni, permettersi vacanze, accedere a nuove esperienze. Il lavoro ha un fine intrinseco che riguarda come ci si percepisce svolgendo (al meglio) il proprio lavoro, che viene prima e sopra ogni altro valore materiale e determina la soddisfazione nello svolgerlo.
A Milano c’è l’imperativo un po’ desueto di non star “mai coi man in man” che traduce il senso operoso della città e, pur riconoscendo la necessità del riposo e anche il contributo alla creatività che lo svago crea, l’attuale economia di mercato avrebbe bisogno di una “cultura” che sappia dare un riconoscimento del valore positivo del lavoro, elemento di dignità, di civiltà e di accreditamento sociale delle persone, sul quale migliorare ed efficientare l’organizzazione del lavoro, che porta poi anche ad un inevitabile accrescimento della ricchezza da distribuire.
La qualità della vita, cioè, non deve solo essere rapportata al tempo libero delle persone, ma anche al modo in cui si interpreta il tempo del lavoro, non solo come fattore economico, ma anche come espressione dell’essere umano, veicolo di valori -integrità, onestà, dedizione, passione- da usare come strumento di crescita personale e collettiva.
L’etica del lavoro, che induce tante persone a lavorare di più e meglio perché se così non facessero si sentirebbero addirittura in colpa, è il risultato di un lungo percorso di evoluzione culturale che ha contagiato nei secoli le generazioni, che andrebbe recuperato e fertilizzato, anche per sostenere la sofferente domanda di lavoro.
“Chi non lavora non fa l’amore” è la canzone con la quale Adriano Celentano trionfò a Sanremo nel 1970, che impose provocatoriamente una riflessione sui temi sociali come il lavoro, fattore di coesione anche affettiva, nel quale ancora riconoscersi e di cui continuare ad essere orgogliosi.